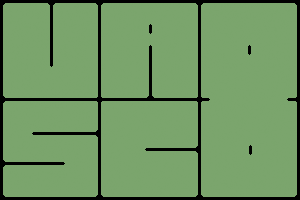Erano venticinque giorni che il cielo pioveva molto meno di quanto minacciasse di farlo. A volte l’aria era inondata da una specie di acqua vaporizzata che però non era propriamente pioggia; né tantomeno possedeva le sue proprietà liberatorie. Tutto era avvolto da un'atmosfera grigia, pesante e indecisa. Troppo maledettamente indecisa. Ogni volta che ci pensavo, mi tornava in mente quella che avevo respirato in un coagulo di casette di pescatori abbarbicate su una scogliera del mare del nord. Lassù la gente viveva tutto l’anno assieme alle nuvole, e d’estate veniva ricompensata dal sole fino alle undici di sera. Qui ed adesso invece farà presto buio, anche se saranno appena le…
Guardai l’orologio. Erano appena le quattro, ed il giorno già se ne stava andando. Altro che sole di mezzanotte. Qui, il buio in arrivo era l’unica cosa certa di un universo in cui l’indecisione regnava sovrana. Sopra la mia testa il cielo non riusciva a decidersi a piovere per bene, sfogarsi, e buttare fuori un cielo stellato da urlo.
Guardai di nuovo l’orologio. Ancora le quattro. Le stesse lancette erano indecise se procedere oppure fermarsi a quell’ora del pomeriggio.
Sorrisi perché, anche la prima volta che avevo letto l’ora su quest’orologio, molti anni prima, erano state le quattro.
Mi avevano appena fatto fare la cresima. La primavera dell’ultimo anno di elementari, e mi è sempre piaciuto pensare a quest’orologio soltanto come al rimborso per lo schiaffo del vescovo, e non come anche al premio per la fine del primo ciclo di studi. Magari ho iniziato proprio quel giorno a detestare i regali che servivano a coprire più ricorrenze. Nascondevano qualcosa di subdolo. Parlavano sottovoce di povertà, o se non di vera e propria miseria, almeno di limiti e ristrettezze economici. Il regalo unico era peggio del non ricevere nulla. Il nulla sarebbe stato la miseria. Il regalo unico per due ricorrenze era il “voglio, ma non posso”. L’ipocrisia, e così mi sembrava quasi che fossero regali che bisognava pagare, anzi, addirittura che fosse corretto pagare, e che il pagamento potesse tranquillamente e avvenire in automatico, sotto qualsiasi forma, e protratto nel tempo proporzionalmente al valore del regalo.
La prima cambiale del debito implicito innescato dall’orologio per la cresima e la fine delle elementari, la pagai dopo una lunga battaglia con le donne che vivevano in casa, e dopo aver sentito ogni sorta di ricatto. Il pagamento consisteva nell’indossare per la cerimonia, un monopetto tre bottoni beige, abbellito da un foulard nel taschino, pantaloni a zampa, e maglione dolce vita, tutto marrone. Il maglione era l’unica cosa di quel look che mi piaceva. In realtà faceva schifo, ma quando me lo toglievo al buio, mi divertivo un mondo. Sembrava mi prendessero fuoco i capelli, tante erano le scintille che si sprigionavano da quel filato sintetico. Lo so. Avrei dovuto resistere, ma non potei che cedere. L’alleanza delle donne di casa era solidissima, e possedeva il potere di soddisfare tutti gli altri miei bisogni. Non potevo farmela nemica. Indossai tutto con molta riluttanza, ma senza dire niente.
Purtroppo, non paghe della prima cambiale, l’alleanza si era sbizzarrita anche sull’acconciatura. Non posso quasi pensarci. Prima di uscire mi sono guardato nello specchio dell’andito pettinato gonfio con la riga in parte scolpita nella lacca, ed ho pensato che non ero male come Big Jim vestito per la cresima. L’alleanza, invece, era davvero entusiasta del lavoro fatto. Soltanto una donna aveva manifestato di non gradire quella mise, e me lo aveva detto dritto in faccia appena mi aveva visto sul sagrato della chiesa.
Terza cambiale. Quella era una donna dell’alleanza cui io non potevo, e non dovevo dire niente mai…
«è antico per te! Hai dieci anni! Guarda tuo cugino Alberto…»
«non è mio cugino… signora maestra…»
«non importa! Il beige non ti sta bene… sei biondo…»
«mi sa che in casa non c’era altro… signora maestra…»
«non contrastare anche in chiesa!»
«…»
Proprio perché non le dovevo, e non le potevo dire niente, sempre, tanto valeva contrastare, sempre.
Alberto ed io eravamo nati e cresciuti assieme. Avevamo abitato uno di fronte all’altro nello stesso condomino per vent’anni. Avevamo frequentato le medesime scuole, spesso le stesse classi, dall’asilo alle superiori. Avevamo persino il medesimo cognome, e per tutta la vita, la gente ci aveva tormentato chiedendoci se fossimo parenti.
No!
Non poteva essere mio parente uno che già da piccolo era identico a Fernandel. Nemmeno alla lontana. Magari alla lontanissima, forse, ma non credo!
Il giorno della cresima, Alberto aveva un vestito spezzato come me, solo giacca blu e pantaloni grigi, camicia bianca e cravatta scura. Fortuna che ero io quello l’antico! Aveva inizio quel giorno la mia diffidenza per giacche e cravatte.
Non avevo più visto la maestra da quel giorno. Era stata la mia maestra per tutti e cinque anni delle elementari, quelle serie, quelle con l’esame in seconda, che ci si poteva restare. A quei tempi aveva fatto di me una specie di suo domestico. Sempre grazie a ricatti. Mi faceva fare un casino di commissioni e servizi per lei dopo la scuola. Naturalmente sempre gratis, almeno a livello monetario. Pensavo che tutti quei servizi avrebbero potuto rendermi la vita a scuola meno dura, e non avevo detto mai di no. Nella realtà però, cambiava poco o nulla. Continuava a lamentarsi del mio risparmiato impegno, ma soprattutto della straripante vivacità che mi pervadeva, e che pervadeva i suoi giudizi scritti, quelli che restavano negli archivi, come la fedina penale…
“Scolaro buono e vivace, ma che si è adeguato alle norme di vita scolastica.” Una volta…
“Scolaro molto buono, ma altrettanto vivace ed irrequieto. Molto socievole. Portato alla vita di gruppo. Sempre pronto ad aiutare i compagni abbisognevoli.” Un'altra volta.
Diverse volte in un anno. Per cinque anni. Gran cazzata i giudizi!
Ero uno “scolaro”, e accostavo sempre questa parola a somaro. Mi ero “adeguato alle norme”, anche se non mi ero accorto che prima di entrare in una scuola non ero a norma. Avevo compagni abbisognevoli, e questo mi faceva un’immensa impressione, perché pensavo che gli abbisognevoli riempissero le missioni, o i lebbrosari, non le classi elementari. Ero “portato alla vita di gruppo”, e con gli anni magari anche all’amore di gruppo. Nella “educazione logico-matematica” ero “versato”, come il latte su cui non si doveva piangere. Avevo “il senso della responsabilità”, che non ho ancora capito se è un sesto senso, o un’inculata mondiale? Ero “un ragazzo maturo”, cui quindi non restava che marcire. Dovevo ancora compiere dieci anni, ma la maestra voleva avere già a che fare con un ragazzo, e non solo lei. Il mio rendimento religioso era buono. Avrebbe dovuto essere ottimo, come tutto il resto della scuola. Meno male che la domenica servivo messa, ed ogni tanto aiutavo il prete a benedire le case! Altrimenti mi sarei trovato un giudizio religioso peggiore, e non sarebbe stato carino nei confronti del Signore. Potevo fare qualcosa? Impossibile! Ogni giorno cinque sei ore di un’intensità immensa. L’ora di religione era respirare, e poi suor Pierina la conoscevo bene dalla parrocchia, e quasi mai le dava fastidio qualcosa, tanto che anche uno “scolaro buono e vivace” come me, doveva applicarsi per vederla incazzata. Io ci sono riuscito, perché mi ci sono applicato di brutto, perché farla incazzare era una questione di principio, ma mi sono messo paura per quanto era diventata rossa in viso.
Con la maestra, compensavo la condotta, con commissioni, favori, e dei discreti risultati. L’eterno ricatto. Ad ogni richiesta della maestra non dicevo mai di no. Era un’insegnante vecchia maniera, non si scherzava, o volavano bacchettate sulle nocche. Per sopravvivere ai cinque anni delle elementari, ero stato costretto a studiarla quella donna. Per anni, e per paura. La temevo per quel suo modo militaresco di controllare i bambini. Tutte le sue classi la temevano. Solo il suo nome mi metteva ancora soggezione. Compresi di odiarla di cuore, decidendo che non l’avrei rivista, mai più.
Ma poi perché mai più?
Ora sarà oltremodo vecchia per mettere paura. Vederla non mi preoccupava più. Sicuramente sarà un’innocua vecchia, stanca delle chiacchiere, del mondo, di se stessa, della vita.
E poi davvero, perché mai più?
«pronto? Buongiorno signora maestra, sono Vascotto, si ricorda? No… non Alberto, Matteo… no, no… noi non siamo cugini… bene… senta… mi scusi se l’ho disturbata a quest’ora… ma io vorrei incontrarla… vorrei venirla a trovare… non è mio cugino le ho detto… si… sono libero… l’ora che preferisce… anche subito? OK… allora… a tra poco… niente… grazie a lei… arrivederci… si, si, sta bene! Non è mio cugino… grazie ancora… a tra poco, allora…»
Poco più tardi suonai al campanello della maestra delle elementari. Lei mi aprì senza domandare chi era. Non ci andava mai nessuno a trovarla? Salii le scale a quattro a quattro. L’atmosfera di frutta di gesso, e stucchi liberty, mi avvolse, accompagnandomi fino a davanti alla porta dell’appartamento, dove con un colpo di tosse le feci capire che ero arrivato. Sentivo che la maestra era dietro alla porta ad aspettarmi. Mi aprì, e mi si parò davanti. Era alta almeno la metà di come l’aveva riesumata la mia memoria. Era tutto più grande da piccoli, e soltanto dopo tanti anni mi sono reso conto che il metro dei bimbi è più corto e meno preciso…
«buongiorno signora maestra…»
«ciao Alberto!»
«Matteo!»
«si, si… accomodati…»
«grazie… come sta?»
«bene, bene… grazie… e tua madre?»
«bene… grazie…»
«ed il papà? È vivo?»
«si, si… certamente… vivo… e attivo…»
Entrammo nel salotto, e ci avvicinammo a due poltrone…
«siediti… sei alto… mi fa male la cervicale a guardarti da quaggiù…»
Un’inaspettata sicurezza di parola ed una fermezza dei gesti e nelle affermazioni, mi fece tornare a galla il disagio che mi procurava ai tempi della scuola. Durò poco. Era veramente minuscola, ed io me la ricordavo gigante; che sensazione paradossale. Mi misi seduto. La maestra mi passò un tovagliolo. Avevo portato una scatola in metallo di biscotti da tè. La maestra l’aveva aperta, e l’aveva allungata verso di me. Tutto cominciava ad assumere un aspetto meno di circostanza, più intimo…
«la trovo sempre uguale signora maestra…»
Il tempo aveva ricalcato, esaltandoli, i tratti che si era permesso di tracciare già vent’anni prima, senza aggiungere nulla o quasi. Forse quella volta aveva qualche chilo in più, e la protesi in bocca non c’era, ma tutto il resto era rimasto uguale…
«ti ringrazio… ma non tutto è rimasto uguale! Mi manca tenacia, anche se continuo a fare tutto come ai bei tempi… quelli della scuola… a proposito, è venuto anche tuo cugino Alberto a trovarmi… si sposa!»
«lo so! Lavoriamo per la stessa società adesso, ma continua a non essere mio cugino…»
«lavorate anche assieme?»
«purtroppo… non bastava averlo avuto vicino tutte le scuole… ora anche al lavoro… il destino crudele…»
Si alzò per versarmi un po’ di brandy, e mi disse…
«mi tremano le mani…»
Mi fece improvvisamente un’immensa tenerezza…
«lasci signora maestra! Faccio da solo… grazie… si sieda…»
«faccio una vita mite…»
Avevo sbagliato a giudicarla così duramente, ma a tempi della scuola non avevo alternative. Non potevo pensare diversamente…
«che anni erano?»
«dal 74… al 79…»
«l’avevi recitata tu la commedia di Stringher, o Alberto?»
«tutti e due… due parti diverse s’intende…»
Sorrise. Un po’ di pasta adesiva per la dentiera le macchiava quel sorriso sincero. Cavalcai l’entusiasmo…
«perché ci obbligava tutte le mattine, dico tutte le sacrosante mattine, prima a pregare, e poi a cantare l’Inno d’Italia?»
«era giusto farlo…»
«anche la Canzone del Piave? O Vecchio Scarpone? O Signor Capitano era giusto cantare?»
«era giusto ricordare…»
Non era cambiato nulla in lei. Vent’anni prima la vedevo già così vecchia. Eravamo seduti sulle poltroncine del tavolo da gioco del suo salotto, e man mano che ricordavamo, mi si risvegliavano ricordi nitidi e chiari. Lei invece, vedeva tutto come attraverso delle diapositive a dissolvenza che le s’incrociavano nella testa. Flash di quaranta anni abbondanti d’insegnamento si accavallavano, si confondevano, e la facevano sentire più vecchia di quanto era veramente, perché in realtà era ancora molto viva…
«ho fatto l’abbonamento in tre teatri, e leggo libri in continuazione… guardo poca tv… ed ogni mattina, con le amiche, cammino sul lungomare fino al castello di Miramare…»
«ogni mattina?»
«ci ferma solo la pioggia… la neve… e il sole che d’inverno tramonta alle quattro del pomeriggio… come oggi…»
«e dopo?»
«dopo il tramonto, mi rifugio nel mio centro cittadino… è tanto ostico e malsano con tutte queste macchine e tutto questo smog, ma è così sicuro pieno di gente… è vicino ai miei luoghi… alle mie amiche… alla chiesa… ci vado ogni sera…»
Proprio come tutti i vecchi, pensai. Le religioni si erano sviluppate proprio per questo senso d’appassimento che l’essere umano riscontra su se stesso con il passare degli anni. I vecchi avevano bisogno di credere in un Dio. Dio dava la giustificazione logica, e plausibile, per comprendere, ed accettare, la precarietà di un’esistenza effimera. Solo credendo o sperando in un qualcosa “dopo”, si può accettare la più tragica, perché inevitabile, delle situazioni della vita: la sua conclusione. La maestra, nonostante tutto, non pensava alla morte; anzi, era un fermento di molti progetti…
«l’anno prossimo… beh… forse tra due, vorrei vedere Londra! Non ci sono mai stata… e mi piace l’idea di visitarla…»
«non ci sono mai stato nemmeno io… un giorno… forse…»
«un giorno, un giorno… chi ha tempo, non aspetti tempo! È utile per non soffrire durante la vecchiaia, e per non sentire l’anticamera della morte…»
«pensa alla morte?»
«non mi spaventa morire… soffro… anzi, mi arrabbio, perché non c’è più la forza e la tenacia di un tempo…»
Mi parlava e mi trattava, come ai tempi delle elementari, soltanto che resisteva molto meno. Cedeva dopo aver capito, dopo essersi resa conto, che di fronte non aveva un bambino fragile ed emotivo ma un uomo, cresciuto, forte e molto più giovane di lei…
«mi manca la resistenza di un tempo. Di quando frequentavo la Trieste che contava. Di quando rimanevo concentrata intere notti davanti ad un tavolo di bridge. Eh l’età, l’età! Adesso sono costretta a giocare a pinnacolo, perché il bridge, con i suoi calcoli, mi fa venire dei mali di testa che non mi fanno dormire… ma sono sempre innamorata della matematica e il mio sogno è stato sempre quello di lavorare in una banca… rimpiango di non averlo fatto… ma mio marito mi concesse solo d’insegnare… ed io ho sempre accettato questa sua volontà… sai Matteo? Bisognava essere prima moglie e dopo donna…»
Prima moglie, e poi donna!
Altri tempi. Ora realizzo chi era questa mia maestra, cinquanta, o sessant'anni fa. Mi aiuta un dagherrotipo granuloso, ritoccato e sfumato ai bordi, incorniciato da un argento oramai nerognolo dalla poca cura e dal tempo che la ritrae bellissima come tutte le donne delle foto di quegli anni…
«sono nata e cresciuta con l’Irredentismo, nella città che dell’Irredentismo aveva fatto un credo… una bandiera… ho visto la Grande Guerra… ho frequentato le persone più in vista! Erano tutti amiche e amici di famiglia. Eravamo ancora un po’ tutti legati alle tradizioni… alla pulita precisione Austro Ungarica. L’Italia in una certa forma tradì le nostre attese. Non potei mai perdonare al fascismo di essersi impelagato in sporchi affari con Hitler… o alla repubblica di aver trascinato con se, nella rovina, anche il blasone e la ricchezza borghese accumulata nei decenni! Sai che ancora oggi penso al Duce? A tradire l’Italia non è stato lui, ma i suoi gerarchi ambiziosi e incapaci… quelli che sotto altre bandiere e differenti simboli e credi politici hanno rovinato l’Italia repubblicana…»
Era andata proprio così?
«tu, come tanti altri primi figli triestini di profughi istriani pacifici, ignoranti e semplici, sentivate l’Italia come la vostra patria. Era necessario che io vi sventolassi ogni momento il tricolore davanti agli occhi. Era importante ricordarvi il Piave. L’Africa. El Alamein. la Russia. Uomini come Menotti. Garibaldi. Micca. I fratelli Bandiera. La X-MAS! Con tutti quei comunisti in giro negli anni settanta! Era importante…»
I comunisti?! Mi venne da ridere. Era da molto tempo che non sentivo pronunciare quella parola. Comunisti! Detta dalla maestra poi! Era sembrata davvero una parola ridicola. Chissà perché temeva il comunismo? Ricordai l’intera giornata di lezione sui pericoli che la presenza così vicina del comunismo slavo poteva portare nei nostri equilibri…
«portasti all'esame di seconda una ricerca sulla Grande Guerra, nevvero?»
«si!» risposi sorridendo per il nevvero.
Ero sbalordito dalla memoria che aveva ancora. Pensai di chiederle di dirmi cosa aveva mangiato a pranzo, ed ero sicuro che non se lo ricordava, perché succede così: dopo una certa età, il passato remoto è di gran lunga più lucido di quello prossimo…
«riuscisti a far stare tutta la Grande Guerra… cinque anni di guerra intendo… in un unico foglio di protocollo a quadretti…»
«ho sempre avuto una scrittura piccola…»
«sulla prima pagina avevi disegnato una bandiera italiana con lo stemma della famiglia Savoia… sporca di sangue… a brandelli… che sventolava sul suolo carsico appena conquistato… lo fece tua madre, vero?»
L’avevo ascoltata con la bocca aperta di fronte a tutti quei particolari…
«a mia madre piaceva disegnare, signora maestra… io avevo delle buonissime idee, ma non mi usciva mai niente di bello dalle mani… così io le dicevo le cose da fare, e lei me le disegnava…»
«la bandiera a brandelli?»
«enfatizzava il sacrificio per la patria…»
«ora?»
«ora cosa?»
«quella bandiera com’è?»
Ripensai alla bandiera a brandelli, e mi risi. Mi sembrava ridicolo aver perso tutte quelle vite innocenti per spostare un confine, ora che "confine" era una delle parole bandite dal mio lessico…
«sono un po’ cresciuto! Ora ho spiegazioni differenti. Motivazioni differenti. Altre! Ho molta più diffidenza nei simboli. Avevo fatto disegnare quella bandiera a brandelli per dare risalto all’eroismo dei soldati italiani…»
«l’ho sempre saputo!» m’interruppe seria «il fico non casca lontano dall’albero! Non potevi essere diverso dai tuoi genitori…»
«già… il DNA non è un’opinione!»
La maestra sorrise, e sorrisi anch’io…
«tuo padre era un profugo di guerra… e tua madre era figlia di un carabiniere, e di una napoletana emigrati… tua nonna, durante i quaranta giorni d’occupazione slava, era andata dietro alle barricate a tirare pietre ai titini… con quattro figli piccoli a casa ad aspettarla… tu non potevi essere diverso dal mondo che ti aveva generato e cresciuto…»
«non ci credo più signora maestra!» l’interruppi «ho capito che era plagio, e me ne sono liberato…»
«sapevo anche questo! Ho sempre saputo che sarebbe successo… eppure mi sono comportata con te come un allenatore che crede nel suo atleta più capace ma lo tratta con lo scudiscio perché, incredibilmente solo con la frusta ottiene i migliori risultati…»
«non pensavo a questo mentre mi sentivo frustare…»
«non si capisce mai una lezione quando s’ascolta…»
«quando si subisce…»
«era necessario! Il segreto che contiene una lezione si scopre sempre dopo, quando perde la patina della scena e rimane quello che c’è tra le righe… quello che la aveva generata…»
Squillò il telefono. La maestra si era alzata, ed era andata a rispondere. Io mi alzai con lei, ed attesi in piedi. Sbirciando tra i suoi libri vidi volumi che non avrei mai pensato di trovare. Kerouac poi! Lo vedevo come uno straniero, un intruso in una libreria dove immaginavo esserci solo Bibbia, Le mie prigioni, Dei delitti e delle pene, I promessi sposi e altra letteratura del genere. Mi aspettavo una libreria risorgimentale, romantica. Kerouac lì in mezzo era un po' come se su una tavola ci fossero salmone, caviale, anatra all'arancia ed una lattina di coca o un cheesgburger.
Riconobbi che la vita andava vissuta due volte. Analizzata in età diverse. Mi ero immaginato di andare a trovare un fossile. Già una mummia nella mia infanzia, ed invece sotto la faccia grinzosa, e le rughe solcate dal tempo e dalle esperienze, avevo trovato una donna che in animo suo aveva ancora molte cose da dire, e da fare. Non per molto ancora. La forza l’aveva già iniziata ad abbandonare. La fiducia in se stessa e nel futuro si stava spegnendo. La vecchiaia è un fenomeno a valanga. Presto si sentirà dire di una sua malattia, di un mancato recupero, di una ricaduta, a valanga, finché non leggeremo la sua morte e chi la conosceva non saprà capacitarsene. Ne leggeremo la notizia tra i già abbondanti necrologi sul giornale di questa città, che spera di trovare la strada giusta guardando indietro. Mah…
«era il medico… oh, che gentile… mi hai atteso in piedi…» disse rientrando in salotto, «ho sempre apprezzato tanto la galanteria…»
Ci risedemmo…
«ormai è dimenticata Matteo… questo è un mondo per scortesi e grossolani… ho sofferto molto… ho sofferto di una malattia infettiva che mi ha bloccata in un letto d'ospedale per nove mesi… lo sai che mi ha tormentata in tutto per nove anni?»
Pensai che nove anni fossero un terzo della mia vita. La guardai, e vidi la tristezza, e la sfiducia nei suoi occhi, mentre mi parlava…
«ho subito un furto, sai? Ero fuori a mangiare un gelato con un’amica… e sono entrati!»
«da dove?»
«da dietro… dalla finestrella del bagno…»
«hanno preso qualcosa?»
«non è il valore dei gioielli! Così mi hanno rubato i ricordi! L’incommensurabile valore della sicurezza dentro a casa mia! È un grosso colpo da mandare giù… per chiunque…»
Figurarsi per una vecchia sola pensai…
«non mi sento più sicura a casa. Sono entrati con troppa facilità, e così ogni volta che rientro ho il cuore in gola mentre apro la porta, e ricordo lo sfascio che ho trovato in camera da letto…»
Soffriva molto senza quei gioielli. Non volli chiederle che cosa le ricordavano, ma mi pentii di non averlo fatto. Ero curioso di comprendere il meccanismo con cui, dopo un certo tempo, l’accezione del ricordo legato ad un oggetto superava il valore commerciale del medesimo. I momenti passati di felicità e bellezza che erano attaccati a quei gioielli, non avevano prezzo. Si era fermata. Drammaticamente aveva abbassato lo sguardo in silenzio, enfatizzando la scena con un morso lento e triste ad un mezzo pasticcino, ed un sorso ammalato al bicchierino di brandy, come per aiutarsi a far scendere il dolcetto…
«non ti avrei mai riconosciuto!»
Non sognava la mia giovane età, però m’invidiava la forza. Marcava costantemente il suo territorio facendomi sentire ancora uno scolaro…
«sei sempre un discolo di prima grandezza?»
«un po’ di meno!»
«sei sposato?»
«no…»
«non ti va l’idea?»
«…»
«tuo cugino Alberto si sposa quest’estate…»
«lo so…»
«e… hai la fidanzata?»
«ci siamo appena lasciati!»
«non metterai mai la testa a posto…»
La lasciai dire tutto senza mai contraddirla. In fondo era tutto vero. Mai la testa a posto. Sentivo una gran pena. Non solo per lei. Sentivo una gran pena per tutti. Me compreso. Sempre così precariamente in bilico tra salute e malattia, gioia e sconforto, gioventù e vecchiaia. Siamo sempre incazzati con la vita perché fa sudare tutto, e perennemente incazzati con la morte perché arriva sempre troppo presto. Sospesi per l’eternità tra il bello della natura, e il brutale modo con cui imponeva le regole. A poco servono i soldi che si rincorrono, come automi, per tutta la vita, quando basta che una cellula, la più piccola, infinitesima parte di noi impazzisca e tutto finisca in un paio d’anni. A poco servono gli anni passati a studiare, a fare filosofie cercando una giustificazione che chissà se mai troveremo…
«è tempo che tu vada! Sto aspettando le amiche per il pinnacolo…» mi dice lasciando trasparire che farebbe volentieri ancora due chiacchiere.
«OK… signora maestra…»
La guardai. Era più sola di quanto non avrei mai creduto, più vecchia di quanto non avrei mai pensato, più debole di quanto dimostrava, e forse, anche meno viva di quanto sembrava…
«arrivederci signora maestra… mi stia bene…»
«grazie… si… altrettanto… saluta la mamma…»
«grazie a lei… si riguardi… e scusi l’incomodo…»
«nessun incomodo… quando vuoi! Salutami anche il papà…»
«non mancherò…»
Fece una pausa. come ai vecchi tempi. Una pausa che, come ai vecchi tempi, ti cagavi sotto dalla paura nel viverla…
«non fare il discolo… metti la testa a posto… trovati una buona donna… e metti su famiglia…»
Scandiva ogni parola con movimenti secchi su e giù dell’indice teso, guardandomi dritto, con occhi pieni di lacrime, ma non era pianto…
«lei piuttosto… non vada troppo a ballare la notte…»
Rise di gusto.
Era felice.
Ero felice anch’io.
 Erano venticinque giorni che il cielo pioveva molto meno di quanto minacciasse di farlo. A volte l’aria era inondata da una specie di acqua vaporizzata che però non era propriamente pioggia; né tantomeno possedeva le sue proprietà liberatorie. Tutto era avvolto da un'atmosfera grigia, pesante e indecisa. Troppo maledettamente indecisa. Ogni volta che ci pensavo, mi tornava in mente quella che avevo respirato in un coagulo di casette di pescatori abbarbicate su una scogliera del mare del nord. Lassù la gente viveva tutto l’anno assieme alle nuvole, e d’estate veniva ricompensata dal sole fino alle undici di sera. Qui ed adesso invece farà presto buio, anche se saranno appena le…
Erano venticinque giorni che il cielo pioveva molto meno di quanto minacciasse di farlo. A volte l’aria era inondata da una specie di acqua vaporizzata che però non era propriamente pioggia; né tantomeno possedeva le sue proprietà liberatorie. Tutto era avvolto da un'atmosfera grigia, pesante e indecisa. Troppo maledettamente indecisa. Ogni volta che ci pensavo, mi tornava in mente quella che avevo respirato in un coagulo di casette di pescatori abbarbicate su una scogliera del mare del nord. Lassù la gente viveva tutto l’anno assieme alle nuvole, e d’estate veniva ricompensata dal sole fino alle undici di sera. Qui ed adesso invece farà presto buio, anche se saranno appena le…